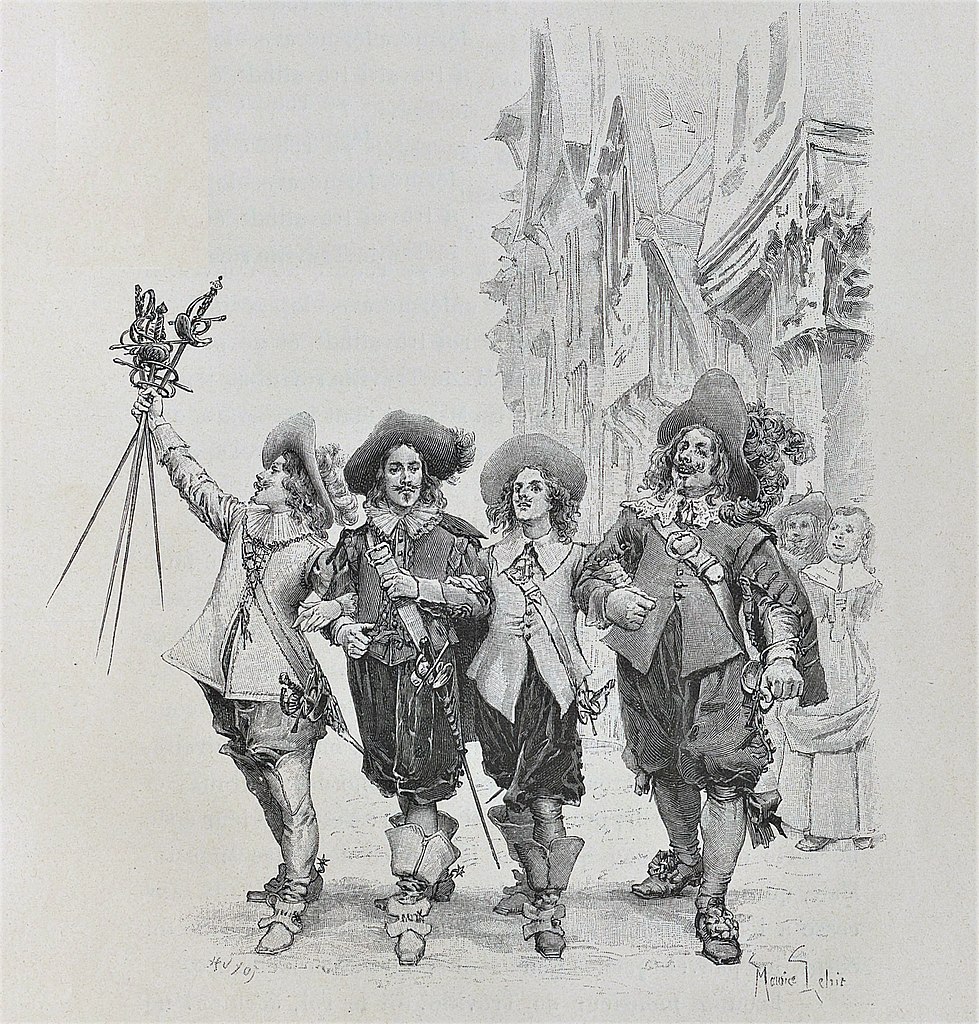All’inizio degli anni Duemila, è apparso un mio libro intervista a Serge Latouche. L’obiettivo di quel libretto era spiegare il suo pensiero nel modo più semplice possibile. In questo ed in altri post ne ripubblico le parti più interessanti.
La prima puntata la trovate qui.
L’economia, se ricordo bene, si inquadra all’interno di un quadro dove regna una fede assoluta nella razionalità occidentale…
Tra il XVI secolo – il Rinascimento – e l’Illuminismo emerge la Modernità, cioè il progetto di costruzione di una città umana sulla sola base della ragione, ripudiando la tradizione e rigettando tutti i legami con la trascendenza, cioè la divinità. Una città universale fatta di individui liberi ed eguali, associati in un contratto sociale, per realizzare la massima felicità divisa nel massimo numero.
Non tutti però hanno la stessa concezione del razionale. Per i greci la ragione aveva due strade: il Lógos – o razionalità – e la Phrónesis – o saggezza, ragionevolezza (Secondo la mitologia greca, Minerva, la dea della ragione, sarebbe figlia di Métis, dea dell’astuzia, e di Zeus. Quest’ultimo avrebbe divorato la madre subito dopo il concepimento. Minerva sarebbe poi nata, già armata di tutto punto, dalla testa di Zeus. Nel libro La sfida di Minerva,Latouche attribuisce alla vergine scontrosa due figli spirituali: Phrónesis, la maggiore, da noi chiamata prudenza o saggezza, o meglio ancora “il ragionevole”, e Lógos epistemonikós, il minore, cioè la ragione geometrica o “il razionale”).
La modernità invece vuole costruire il mondo esclusivamente sulla ragione calcolatrice. Descartes nutre la speranza di fondare una filosofia veramente razionale, cioè dimostrabile al pari di un teorema matematico. Leibniz tenta di mettere al posto del giudizio il calcolo, e lancia il progetto di una matematica universale. Come dice in una delle sue più celebri sentenze “Non discutiamo più, calcoliamo”. Anche Jeremy Bentham immette il calcolo in ogni campo.
Secondo Max Weber la creazione di un diritto “calcolabile”, sul quale si può “contare come su una macchina”, è fondamentale per la nascita del capitalismo in Occidente. Nulla a che vedere con il diritto cinese, che permette a chi ha venduto la propria casa di ritornarvi in possesso se ha fatto cattivi affari. L’economia stessa è un’espressione di questa volontà. L’obiettivo è affidare al solo calcolo – senza tante discussioni – la produzione, la distribuzione e il consumo, con l’intenzione di estendere poi il campo alla totalità del sociale – la società di mercato.
Per questo prima del Rinascimento, l’europeo e, fino a un’epoca recente, gli altri uomini, davano pochissimo spazio nella loro vita all’economia. Ognuno svolgeva i suoi compiti, spesso domestici, e si preoccupava, per quanto riguarda l’uomo del Medioevo, della religione, e per l’indigeno dell’Africa, delle feste o dei rituali. Del resto la parola “economia” era allora assente nella maggior parte delle lingue.
Ma oggi ciascuno partecipa alla vita economica e possiede un minimo di conoscenze, fedi, o miti, che riguardano l’economia. L’imprenditore si preoccupa dei tassi d’interesse e dei prelievi fiscali, e la casalinga del prezzo del burro e dei versamenti all’INPS. Sono tutte categorie economiche.
Quale giudizio si può dare a questa razionalità elevata ad unica legge che deve reggere il mondo?
Può essere legittimo obbedire ad un calcolo razionale quando acquistiamo delle azioni in borsa, ma non quando facciamo lo stesso per regolare problemi che riguardano gli uomini. Prendiamo un problema concreto: bisogna aprire il mercato francese ed europeo senza porre dei limiti alla concorrenza esterna? Ci sono argomenti a favore ed argomenti contro e li conosciamo da tre secoli. E ora, di colpo, il pensiero unico economico ci impone la sua razionalità, ed è l’apertura totale, il libero scambio assoluto. Così facendo si rovinano migliaia di persone, si distruggono centinaia di saperi, di tradizioni per rimpiazzarli con poco o nulla.
L’applicazione della razionalità in ogni campo è irragionevole. La sua ossessione per la quantificazione porta a ridurre tutto a grandezze quantificabili. Così facendo ha ridotto la felicità al piacere, il piacere alla soddisfazione dei bisogni materiali, il bisogno al quanto si consuma, e tutto questo al Prodotto Interno Lordo e al denaro.
Il paradiso, sia pure artificiale, diventa la società consumista. La maggior felicità per il maggior numero è produrre e consumare di più, anche se tutta la filosofia dice che l’assenza di limiti sia l’opposto della ragione.
L’efficienza economica è l’applicazione della razionalità strumentale come legge suprema. Ma in cosa consiste tale efficienza nel costruire, che so io, una casa? Quale sarà il materiale più efficiente? Il cemento? La pietra? Il mattone? Il fango? Il legno? Quale sarà il suo orientamento? I colori e la posizione? Come giudicare la Levis, che pretende di aver inventato “the ultimate jeans”, i jeans definitivi? Il fatto che questo vestito sia diventato la divisa mondiale dell’uomo comune prova che esso sia il vestito migliore?
Tutto ciò dipende dai gusti di ognuno. Solo che la razionalità tende ad uniformare anche i gusti, per arrivare a un calcolo oggettivo. L’efficienza sarebbe un concetto vuoto, e i jeans Levis non sarebbero definitivi, se ogni persona decidesse secondo la sua personalità, e ci fosse un solo cliente per modello.
E poi chi è l’homo oeconomicus, l’uomo razionale per definizione? Già Cartesio pensava che il soggetto del cogito fosse doppio, qualche tempo dopo Freud parlava di un soggetto con tre identità – l’Io, il Super-io e l’Es -, mentre i “selvaggi” samo – una tribù del Burkina Faso – ne individuano addirittura nove.
Cosa si può contrapporre a questa razionalità che finisce per essere irragionevole?
La retorica, è l’arte di porre i problemi della città, di convincere e persuadere, di cercare la verità, di soppesare gli argomenti in modo da arrivare alla soluzione più ragionevole nello spazio delle conoscenze.
I Greci l’avevano capito bene: la ragione ragionevole non emette sentenze definitive, arriva a decidere – provvisoriamente – dopo aver soppesato argomenti contraddittori. Questo porta a sviluppare la retorica, e a riportare le “scienze” sociali e umane, che un tempo – più giustamente – venivano chiamate filosofia morale e politica, all’interno di questo campo.
Fare un simile passo implicherebbe molte altre cose. Bisognerebbe ammettere che non esistono distanze incolmabili tra le dottrine che indagano sull’uomo e la società, e tra queste e la letteratura. Pensiamo solo ai grandi romanzieri e poeti: spesso ci hanno detto più cose sulla società dei cosiddetti “scienziati sociali”. Significherebbe riconoscere che convincere e sedurre sono parte integrante del lavoro dello “scienziato”: non è un caso se alcuni fra i più bei testi filosofici e sociologici hanno sfruttato appieno la forza e il fascino delle parole.
Insomma, per rimanere ragionevole, la Phrónesis, o saggezza, deve guardarsi dal pericolo della deriva in un rigore e in una freddezza esclusivi e inaridenti.